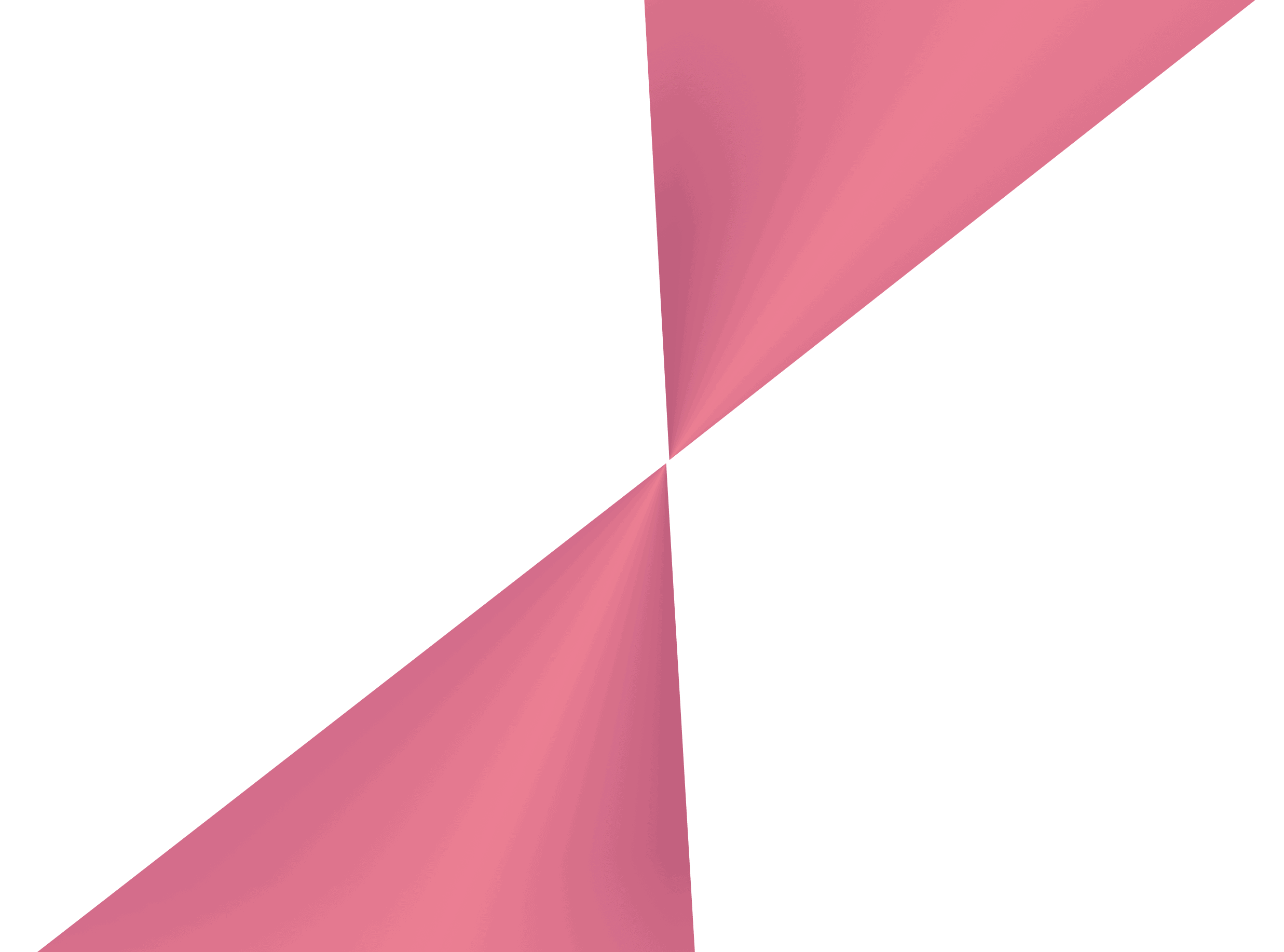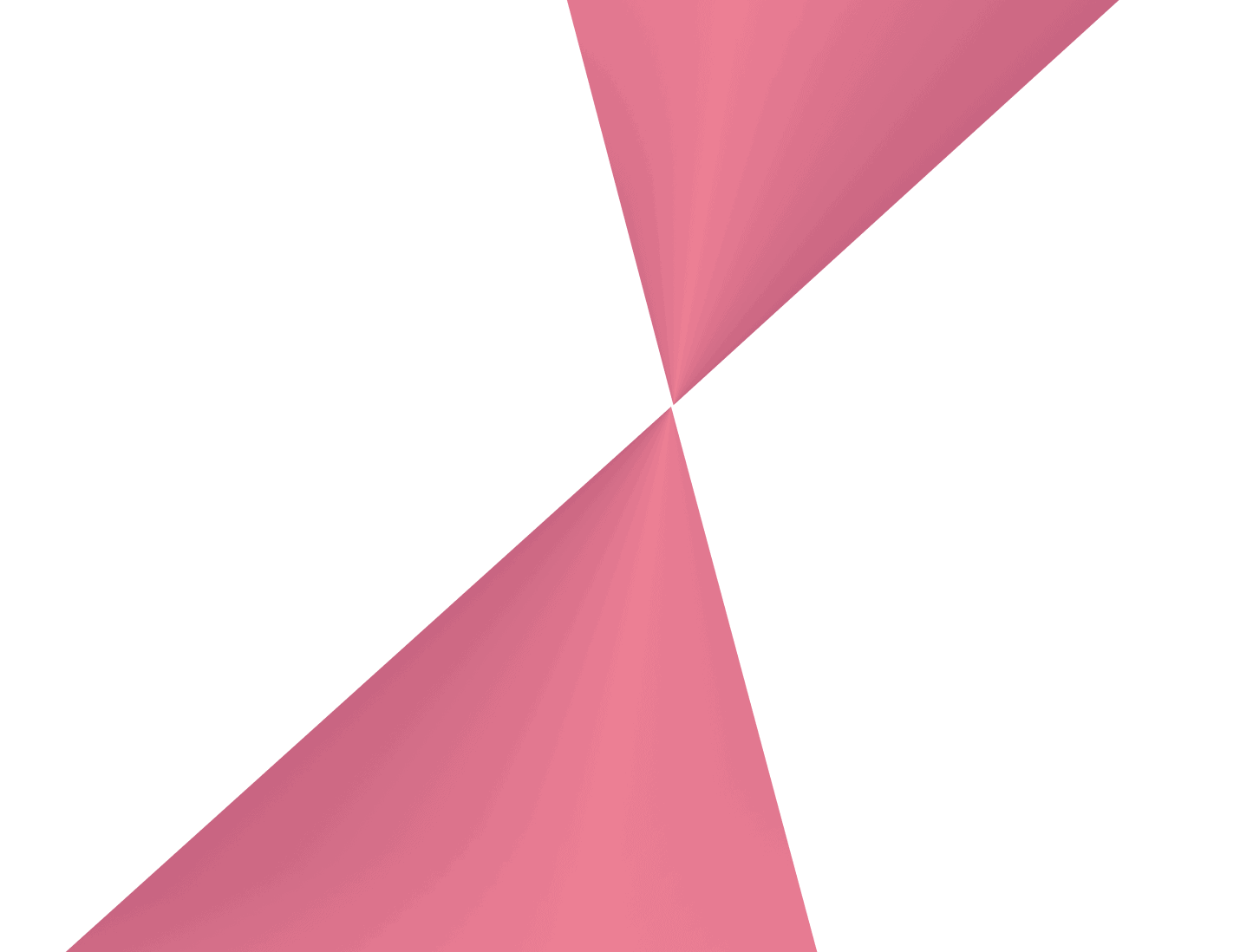Con sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025, la Suprema Corte di Cassazione con un’interessante decisione ha delineato il concetto di “continuità aziendale” e i criteri di accertamento che devono essere impiegati, in relazione al giudizio di omologa di una proposta di Concordato Preventivo “misto”.
Come noto, la proposta di concordato preventivo misto è caratterizzata dalla combinazione dei profili propri delle altre due tipologie di proposta, ossia quello della continuità aziendale e, al contempo, quelli tipici delle procedure liquidatorie, al fine di addivenire alla ristrutturazione del debito e alla soddisfazione del ceto creditorio.
La sentenza, pronunciata tramite l’applicazione della legge fallimentare, è particolarmente utile anche utilizzando, mutatis mutandis, la disciplina di cui al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza attualmente vigente.
I FATTI DI CAUSA
La vicenda trae origine dall’impugnazione con ricorso immediato in cassazione ex art. 111 Cost. del decreto di omologa di una domanda di concordato preventivo misto.
Il piano concordatario prevedeva la soddisfazione dei creditori tramite i flussi di cassa derivanti dalla prosecuzione dell’attività aziendale, nonché dagli introiti ricavabili dalla liquidazione di una società controllata sita all’estero e di due beni immobili del socio unico e amministratore della società, quindi non direttamente funzionali all’attività d’impresa.
La prima questione problematica, emersa in sede di esame della proposta da parte dei creditori, era proprio la mancata indicazione delle modalità con le quali si sarebbe svolta l’attività liquidatoria, posto che a tale attività era intenzionato a provvedervi direttamente il socio unico oltreché amministratore della società. Logicamente, la mancata previsione della nomina di un liquidatore giudiziale e le modalità di liquidazione degli asset è un dettaglio non indifferente per la presentazione del piano al Collegio.
Nonostante quanto sopra, il Tribunale, al fine di superare questa situazione di stallo, nel decreto di omologa del concordato preventivo ha provveduto alla nomina di un commissario liquidatore con poteri circoscritti alla liquidazione degli asset previsti per l’adempimento della proposta.
Le ragioni del gravame si fondavano essenzialmente su come dovesse essere organizzata l’esecuzione di un concordato misto nel caso in cui il piano prevedesse pure la dismissione di beni immobili non funzionali all’esercizio dell’attività di impresa.
I sei motivi sono così riassumibili: (i) se sia possibile provvedere nella fattispecie in esame alla nomina di un liquidatore (e di un comitato dei creditori), quand’anche il piano escluda una simile eventualità, al fine di procedere alla cessione di tali beni (primi due motivi); (ii) secondo quali modalità la vendita debba avvenire secondo gli artt. 105 e 108-ter L.F. (ora artt. 214 e 218 C.C.I.I.), oppure anche liberamente sul mercato; (iii) se sia possibile prevedere che alla vendita consegua la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, a mente dell’art. 182, comma 5, L.F. (ora art. 114 C.C.I.I.).
LA DECISIONE
La Suprema Corte, analizzando i motivi di gravame del ricorrente, è giunta alla conclusione che il ricorso promosso era da considerarsi infondato, in ogni sua parte.
Premessa la conformità del mezzo di impugnazione a norma dell’art. 180, comma 3, L.F., la S.C. ha ribadito che la definizione di concordato preventivo misto rimane regolata nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall’art. 186-bis L.F. (ora art. 84 C.C.I.I.), che peraltro, al comma 1, contempla espressamente anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito.
In ogni caso, è stato anche precisato, richiamando l’orientamento costante della stessa Corte, che la norma sopracitata non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, bensì “una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori (Cass. 734/2020)”.
E qui si giunge al punto focale della decisione, in quanto i giudici di legittimità hanno delineato i confini interpretativi della definizione di “continuità aziendale”, nonostante il piano concordatario presupponesse, seppur in parte, una fase liquidatoria. Invero, “la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa e proprio al fine di assumere questa caratteristica, deve tuttavia riguardare, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa del nucleo aziendale, vale a dire (mutuando la terminologia utilizzata dall’art. 2112, comma 5, cod. civ.) (ndr., trasferimento di ramo d’azienda) un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica precedentemente organizzata che conservi la propria identità ed alla quale i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali”.
In buona sostanza, affinché si possa riscontrare effettivamente la soluzione di continuità aziendale è necessario che l’attività d’impresa, seppur considerando un possibile ridimensionamento, prosegua mantenendo le sue pregresse caratteristiche, anche in termini qualitativi, senza subire alcuna destrutturazione né tantomeno modificando la propria attività d’impresa.
Infatti, l’accertamento che deve svolgere il Tribunale deve essere eseguito in considerazione di tutte quelle circostanze di fatto che caratterizzano la proposta di piano (ad esempio, il tipo di impresa, il tipo di attività produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e della clientela, dei beni strumentali necessari per la produzione, e così via).
In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso promosso, confermando il provvedimento impugnato e ponendo in rilievo la correttezza dell’operato del Collegio di primo grado, ivi compresa la nomina di un commissario liquidatore nello specifico caso in cui manchi o si dimostri carente l’esposizione delle modalità di liquidazione dei beni non funzionali alla continuità.
Cassazione civile, sez. I, 08 Gennaio 2025, n. 348. Pres. Ferro. Est. Pazzi >