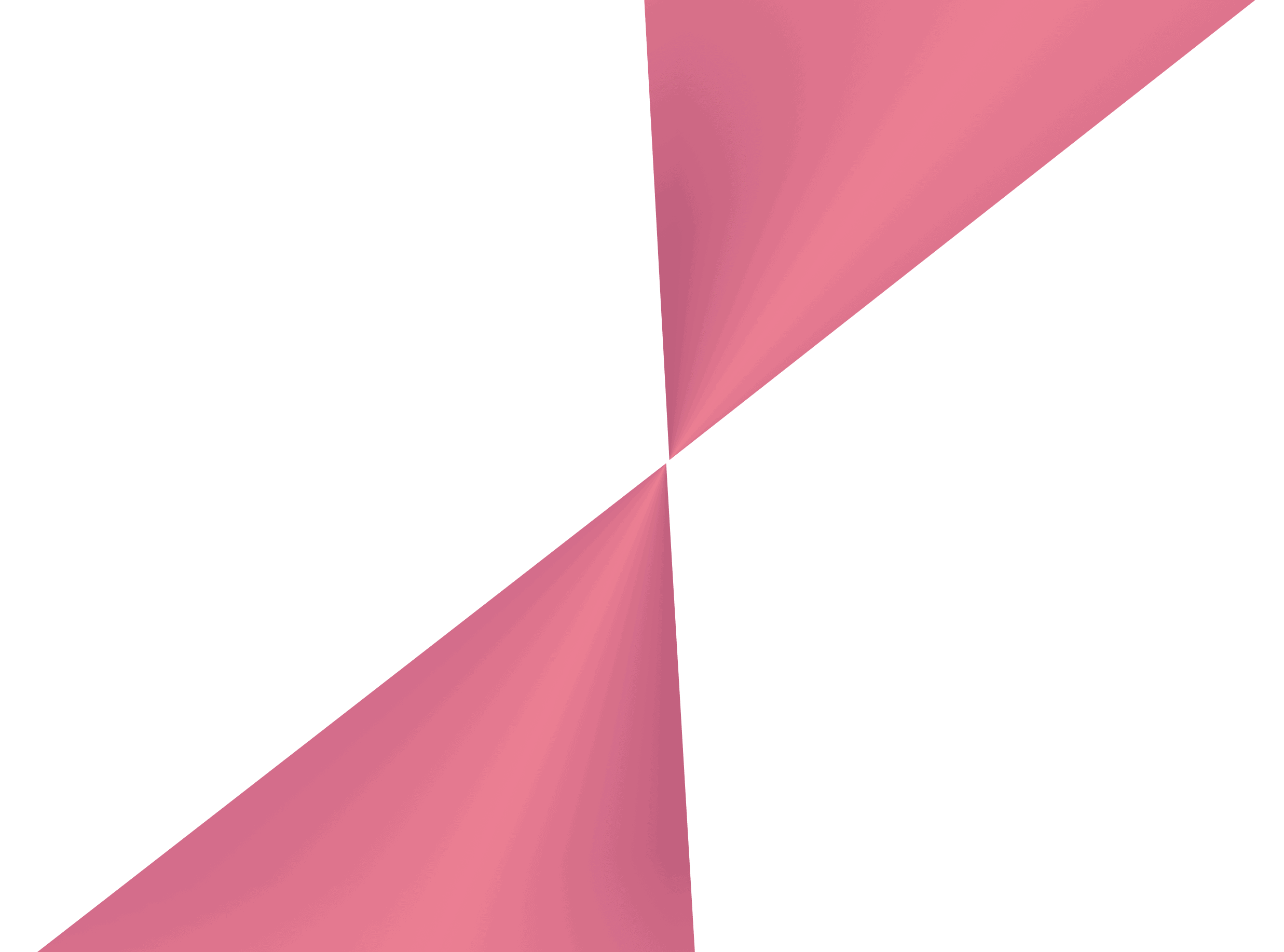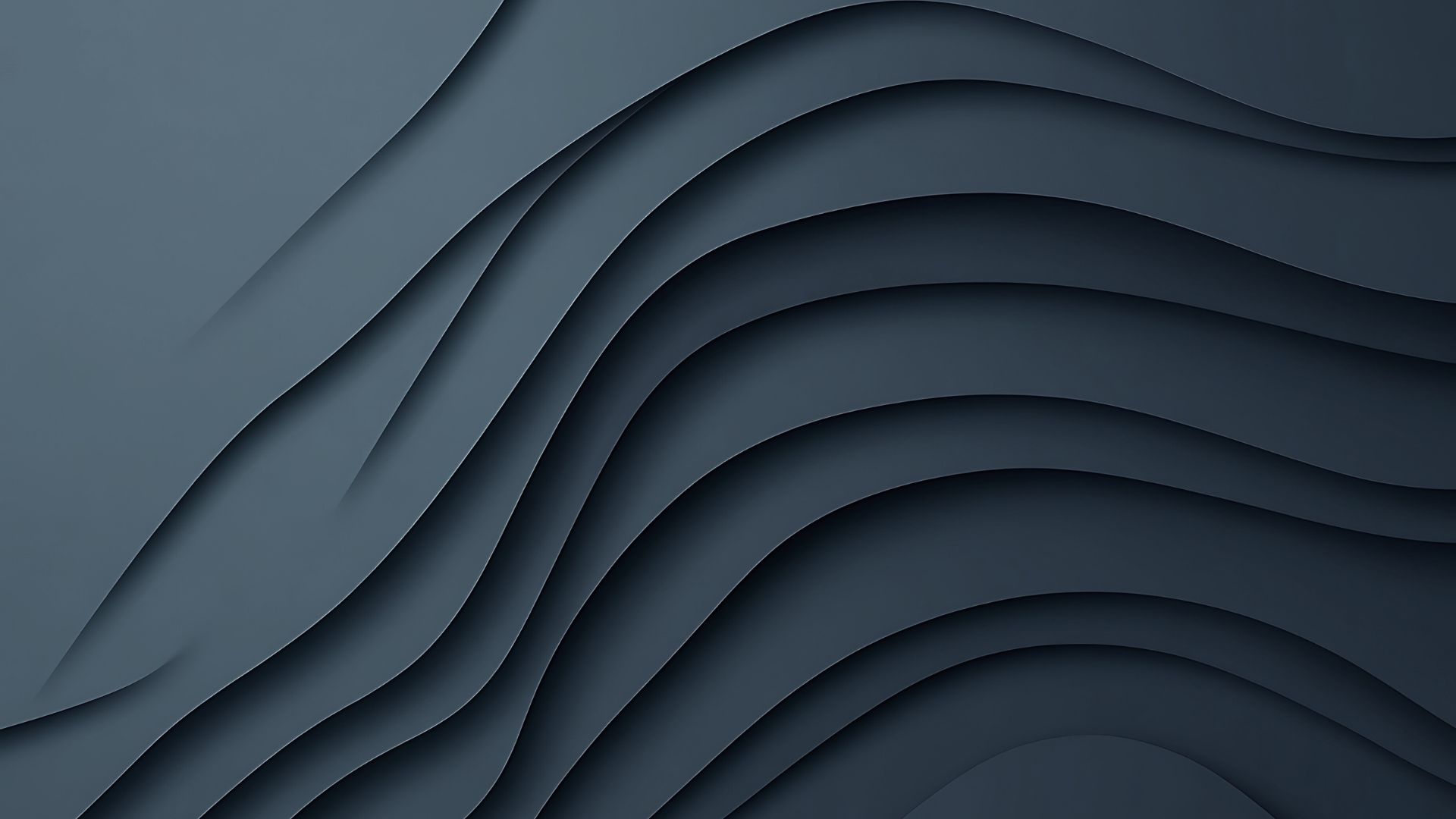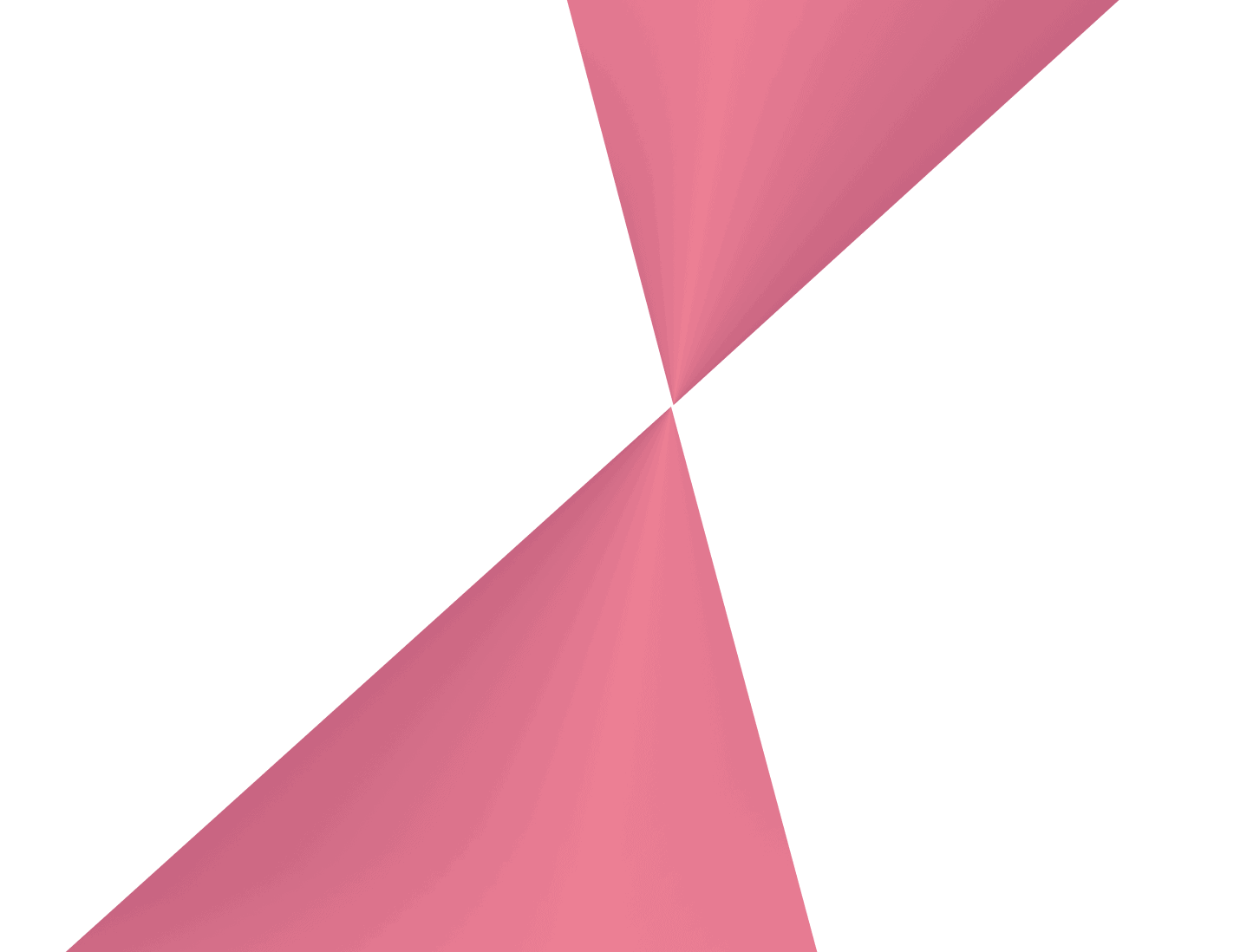La decisione della Corte di Cassazione italiana, n. 20415/2025, ha finalmente riconosciuto la validità degli accordi stipulati tra coniugi riguardanti la regolazione dei loro rapporti patrimoniali in previsione di una possibile dissoluzione del matrimonio.
Prima di analizzare il caso e la decisione, è utile richiamare brevemente il quadro legislativo italiano riguardante l’autonomia contrattuale concessa ai coniugi.
Infatti, l’articolo 162 del Codice Civile italiano prevede che gli accordi matrimoniali possano essere stipulati in qualsiasi momento, anche prima del matrimonio, e debbano essere redatti con atto pubblico per definire il regime patrimoniale stabilito dai coniugi, oltre ad altri aspetti della vita matrimoniale.
Ciò significa che l’accordo deve essere redatto da un notaio italiano, che agisce come pubblico ufficiale per garantire che l’accordo sia autentico, che le parti abbiano la capacità legale e che comprendano pienamente il contenuto e le implicazioni dell’accordo, che deve essere stipulato liberamente e senza alcuna forma di coercizione o influenza indebita.
Tali accordi devono anche essere registrati nei registri dello stato civile mantenuti dall’ufficiale di stato civile locale dove il matrimonio è (o sarà) registrato e possono essere modificati nel tempo, a condizione che venga osservata la stessa forma, garantendo certezza giuridica continua.
Al contrario, l’articolo 160 del Codice Civile non consente ai coniugi di derogare ai diritti e doveri inalienabili stabiliti dalla legge come conseguenza del matrimonio.
Detto ciò, in numerosi Paesi, gli accordi prematrimoniali sono validi e, infatti, la loro esecuzione è una pratica comune nel contesto socio-culturale.
In Italia, la situazione è sempre stata diversa, ma lo sviluppo recente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione sembra aver segnato un punto di svolta significativo. Il caso riguardava due coniugi che, durante il corso del loro matrimonio (nel 2011), stipularono un accordo privato scritto, nel quale si stabiliva che, in caso di separazione, il marito avrebbe dovuto rimborsare alla moglie le somme da lei anticipate per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, nonché per l’acquisto di arredi, descritti come “spese per la ristrutturazione, mutuo e installazione di un nuovo impianto di riscaldamento” e come un “contributo al benessere della famiglia, acquisto di mobili e veicoli”.
Contemporaneamente, la moglie rinunciava al possesso di determinati beni mobili (barche, mobili e somme di denaro).
Dopo la separazione della coppia nel 2019, sorse una disputa riguardo la validità e l’applicabilità dell’accordo del 2011.
Il marito cercò di far dichiarare nullo l’accordo, sostenendo che fosse contrario all’ordine pubblico e alle disposizioni legali obbligatorie (in particolare, gli articoli 143 e 160 del Codice Civile, che stabiliscono i diritti e doveri inalienabili dei coniugi).
La moglie, invece, cercò di far riconoscere l’accordo come valido ed esecutivo.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del marito e confermato le decisioni delle corti inferiori che avevano dichiarato la validità di tale accordo privato tra i coniugi.
La Corte ha riaffermato che i coniugi hanno l’autonomia di regolare i loro rapporti patrimoniali attraverso accordi privati, anche in previsione di una possibile crisi coniugale.
In effetti, l’obbligo di rimborso trovato nella separazione si giustifica nel riequilibrio delle risorse economiche che i coniugi avevano reciprocamente inteso garantire l’uno all’altro, e non è legato al diritto/dovere di sostegno morale e materiale durante il matrimonio.
Tale accordo è, infatti, da classificarsi come un contratto atipico con una condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia contrattuale dei coniugi volta a raggiungere interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322, comma 2, del Codice Civile, poiché il fallimento del matrimonio non è la causa dell’accordo, ma un evento condizionale che ne innesca gli effetti.
L’accordo in discussione è, quindi, lecito perché non viola i diritti e doveri inalienabili dei coniugi, ma prevede un riconoscimento di debito a favore della moglie, in considerazione del suo contributo finanziario, e riconosce anche determinati beni a favore del marito, regolando liberamente, ragionevolmente e equamente gli accordi patrimoniali dei coniugi in caso di dissoluzione della comunione dei beni.
In effetti, la Corte di Cassazione ha sottolineato che non esiste una norma obbligatoria che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l’esistenza di un debito nei confronti dell’altro e di rendere il suo rimborso condizionato al futuro e incerto evento della separazione coniugale.
Ciò che rimane chiaro è che tale accordo in nessun caso può sostituire l’assegno di mantenimento previsto dalla legge, che rimane soggetto a esclusiva determinazione giudiziaria, né può riguardare diritti inalienabili, come quelli relativi ai figli o agli obblighi fondamentali di sostegno.
D’altra parte, i coniugi possono validamente concordare questioni patrimoniali specifiche, come debiti e trasferimenti di beni, che potrebbero successivamente essere prese in considerazione dal tribunale nelle cause di separazione o divorzio.
Inoltre, la legge italiana contempla la possibilità che i coniugi stipulino accordi anche dopo il matrimonio, i cosiddetti accordi postmatrimoniali.
Questi accordi, spesso trascurati nel dibattito pubblico, possono svolgere un ruolo cruciale nel regolare i rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi durante il corso del matrimonio e in previsione della sua possibile dissoluzione.
Gli accordi postmatrimoniali possono essere utilizzati per modificare il regime patrimoniale inizialmente scelto dai coniugi, come passare da un regime di comunione dei beni a separazione dei beni, o viceversa, ma possono anche essere impiegati per affrontare accordi finanziari specifici, come l’allocazione di determinati beni, la gestione dei beni in comune o il rimborso delle spese sostenute da un coniuge a beneficio della famiglia o dell’altro coniuge.
Considerato che anche la recente decisione della Corte di Cassazione ha chiarito che tali accordi, purché eseguiti nel rispetto dei requisiti formali previsti dalla legge, sono validi ed esecutivi, a condizione che non violino i diritti e doveri inalienabili stabiliti dalla legge, il principio che l’autonomia dei coniugi nella gestione dei loro rapporti patrimoniali si estende per tutta la durata del matrimonio.
È importante notare che gli accordi postmatrimoniali, come quelli prematrimoniali, non possono essere utilizzati per predeterminare o rinunciare ai diritti relativi al mantenimento o al supporto per i figli, né possono essere utilizzati per eludere le protezioni legali riservate alla parte più debole nel matrimonio.
Tuttavia, possono servire come strumento utile per chiarire le aspettative e le responsabilità finanziarie di ciascun coniuge, riducendo così il potenziale conflitto in caso di separazione o divorzio.
Alla luce di quanto sopra, si può affermare che la decisione della Corte di Cassazione n. 20415/2025 rappresenti un punto di svolta significativo nel diritto familiare italiano, allineandolo più strettamente a una tendenza europea più ampia che riconosce e tutela sempre più l’autonomia contrattuale dei coniugi nel regolare i loro rapporti patrimoniali e finanziari.
L’obiettivo per il futuro dovrebbe essere quello di riflettere meglio una comprensione moderna della cultura familiare, dove il matrimonio è visto come una relazione in cui entrambe le parti dovrebbero essere in grado di firmare accordi vincolanti per il loro beneficio reciproco, nel rispetto delle disposizioni legali.
A tal proposito, vale la pena precisare che l’Italia ha compiuto alcuni passi rilevanti nel diritto di famiglia, riconoscendo la diversità delle strutture familiari e fornendo strumenti giuridici per proteggere gli individui in relazioni non tradizionali.
Ad esempio, la Legge italiana n. 76/2016 regola le relazioni di “convivenza di fatto”, riferendosi alle coppie che vivono insieme in una relazione stabile e continua, ma che non sono sposate o in un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Infatti, la coppia può stipulare un accordo di convivenza che può regolare alcuni aspetti della loro vita insieme, come il regime patrimoniale, come la coppia condividerà le spese domestiche (affitto, utenze, ecc.), alcuni diritti successori (ad esempio, il diritto di rimanere nell’abitazione condivisa per un certo periodo dopo la morte del partner), il diritto di visitare il partner in ospedale in caso di ricovero, il diritto di prendere decisioni mediche per un partner incapacitato, se così designato, e altre questioni finanziarie.
In breve, questo riconoscimento estende alcuni diritti e doveri ai partner conviventi, che in precedenza erano riservati solo ai coniugi o a coloro che sono in un’unione civile.
Per completezza, l’accordo di convivenza deve essere scritto ed eseguito come atto pubblico o accordo privato autenticato presso un notaio o avvocato italiano e deve essere registrato presso l’ufficio del registro locale per essere efficace nei confronti di terzi. Pertanto, l’obiettivo del legislatore italiano era di consentire alla coppia di definire alcuni aspetti legali della loro relazione, alla luce del principio di autonomia contrattuale, per promuovere una maggiore uguaglianza e non discriminazione, segnando un passo verso una comprensione più inclusiva della famiglia, basata sulla realtà della vita delle persone piuttosto che su definizioni legali tradizionali.
Il diritto di famiglia si sta evolvendo insieme alla società e alle nuove forme di convivenza e relazioni amorose, quindi è più che mai cruciale rimanere aggiornati su qualsiasi cambiamento, sia a livello nazionale che internazionale.