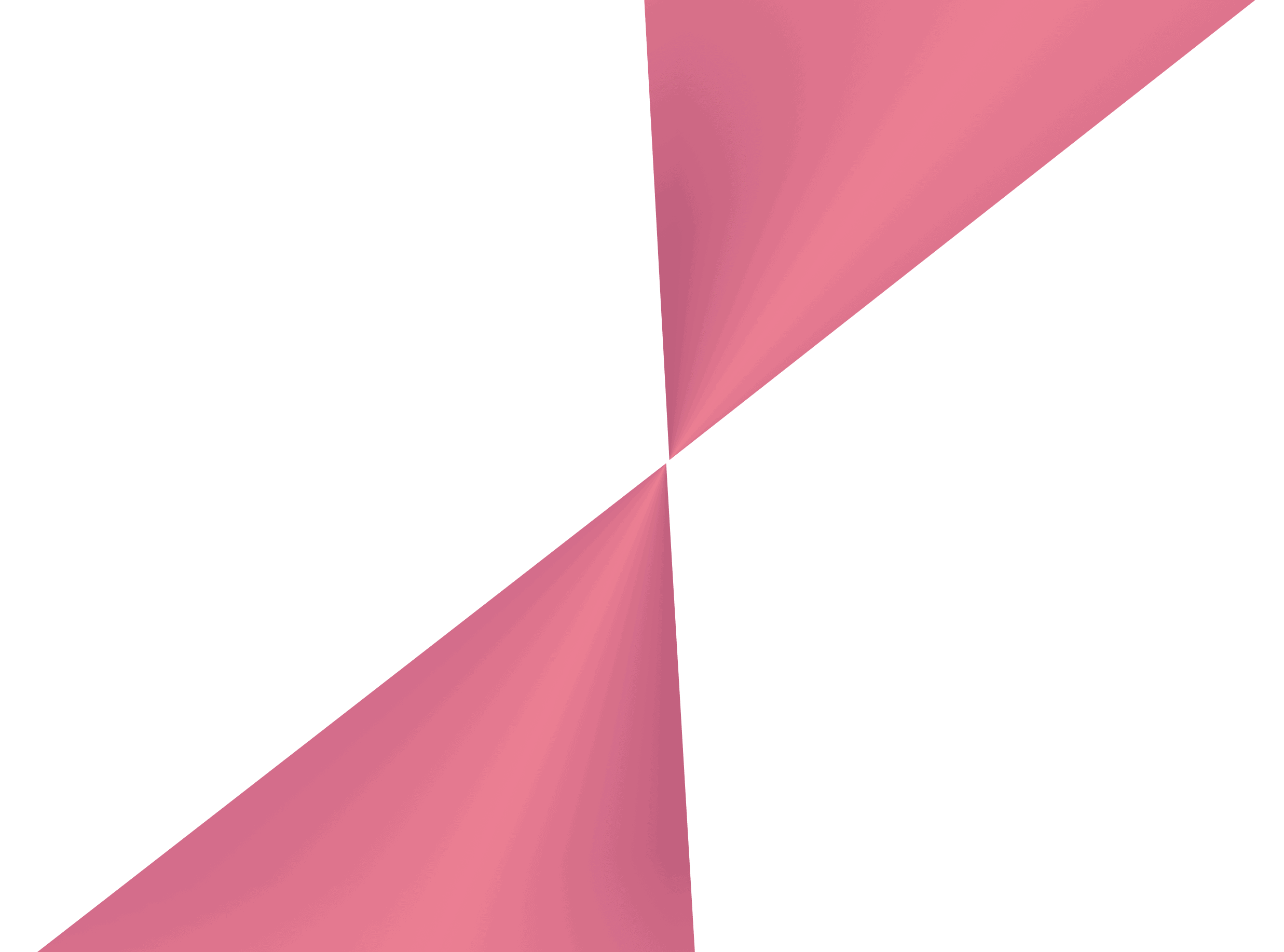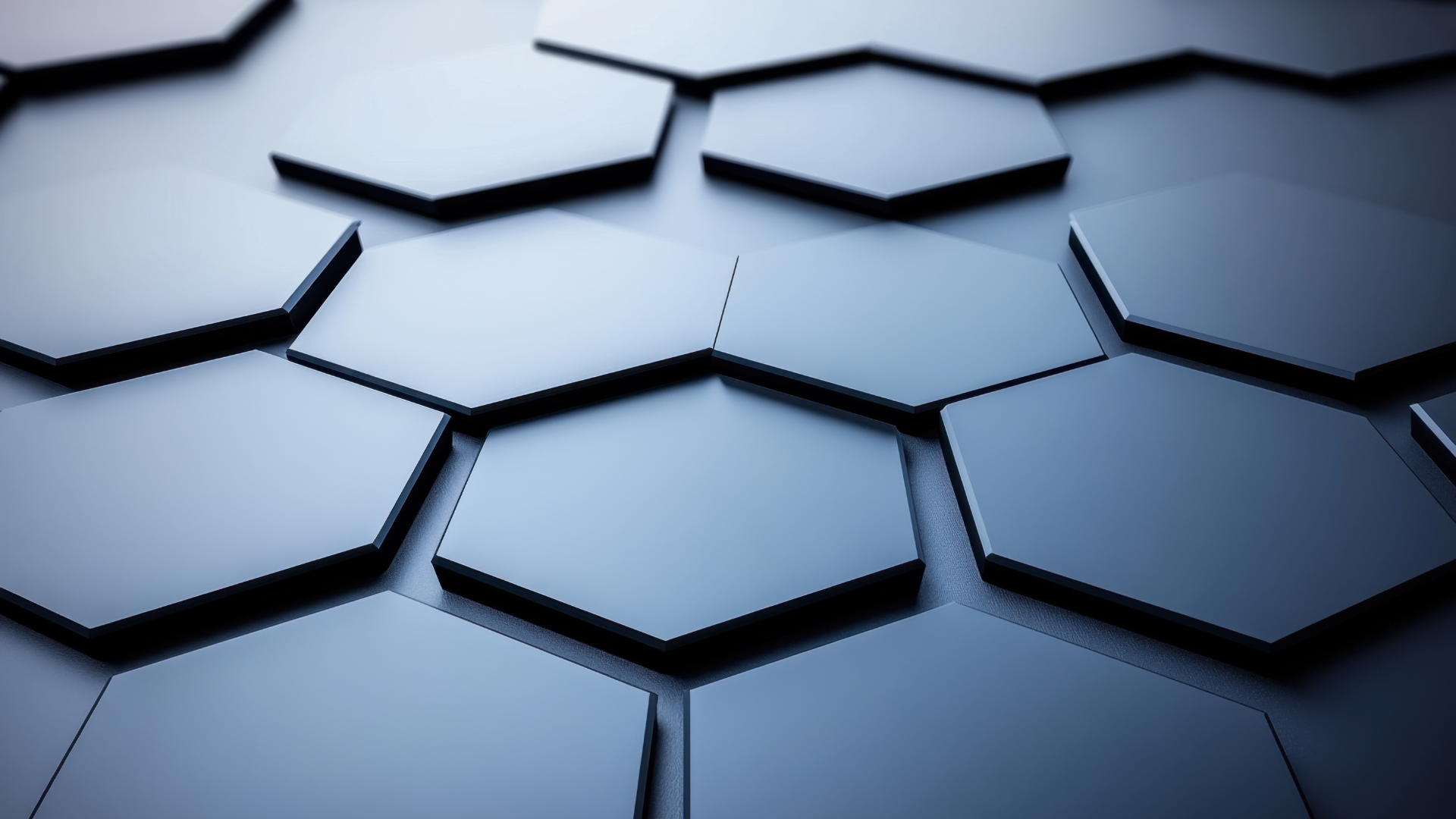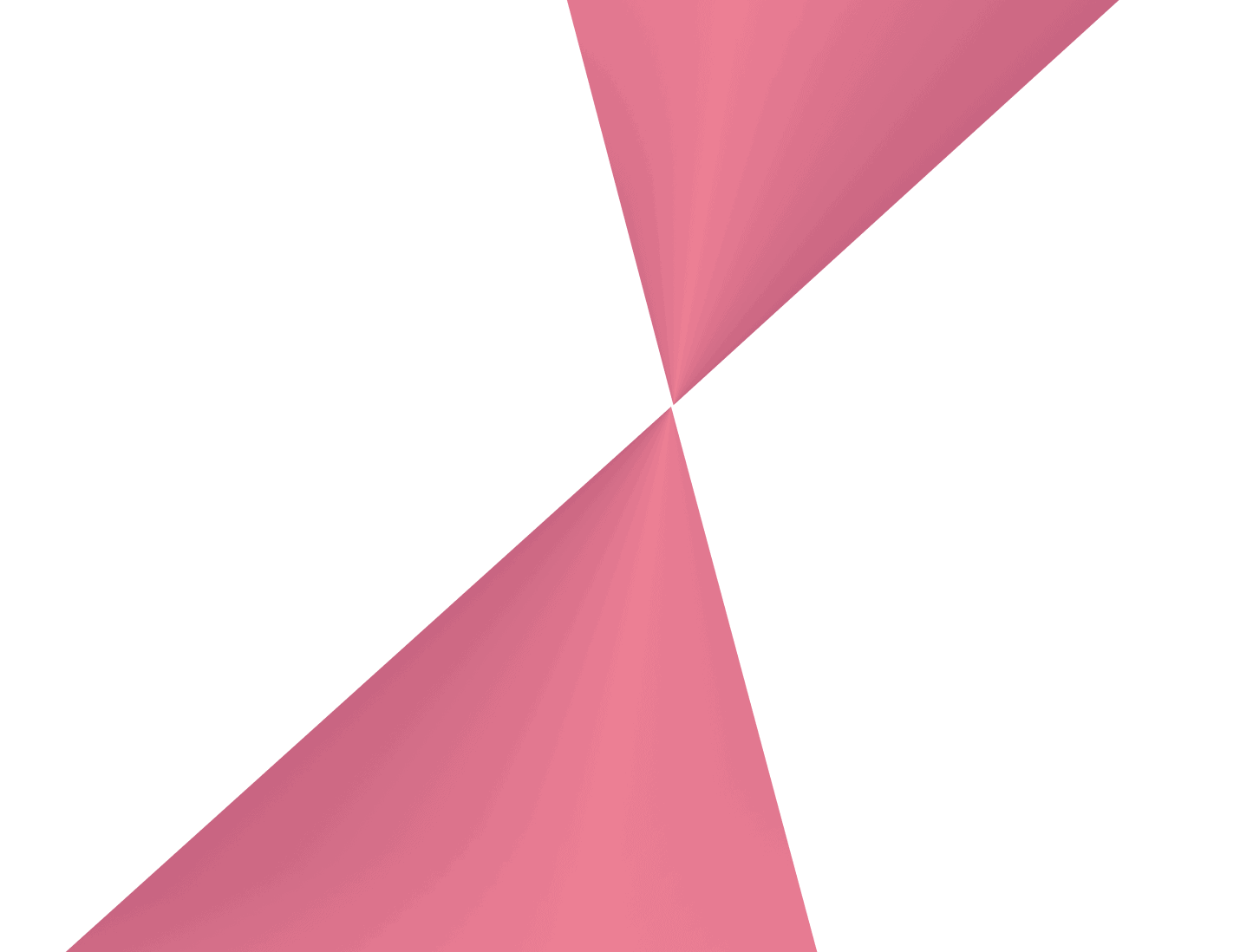L’estrazione di risorse da corpi celesti, comunemente nota come space mining, si configura oggi come una delle frontiere più innovative e, al contempo, controverse del diritto internazionale dello spazio. L’interesse sempre più marcato da parte di operatori privati e policy maker ha reso imprescindibile un’analisi approfondita e sistematica non solo degli strumenti di hard law, quali trattati e convenzioni internazionali, ma anche delle più recenti iniziative di soft law e delle discipline nazionali emergenti. Il presente contributo intende offrire una panoramica aggiornata e autonoma del quadro normativo di riferimento, evidenziando le principali criticità e le prospettive di governance multilivello, con particolare attenzione agli sviluppi più recenti.
Un divieto in evoluzione: dall’art. II OST al bisogno di regole operative
Il Trattato sullo Spazio Esterno del 1967 (Outer Space Treaty – “OST”)1, ratificato da oltre centodieci Stati, costituisce il pilastro fondamentale del diritto internazionale dello spazio: l’articolo II dell’OST sancisce, infatti, il divieto di appropriazione nazionale dello spazio extra-atmosferico, ivi compresi la Luna e gli altri corpi celesti, da parte degli Stati, sia mediante rivendicazioni di sovranità, sia attraverso l’uso, l’occupazione o qualsiasi altro mezzo. Tuttavia, il trattato non disciplina in modo espresso la sorte giuridica delle risorse estratte (risorse in-situ), lasciando così spazio a interpretazioni divergenti e determinando un vuoto regolatorio che ha favorito l’adozione di normative nazionali tra loro eterogenee.
Negli Stati Uniti, la legge federale denominata Commercial Space Launch Competitiveness Act del 20152, attribuisce ai cittadini e alle imprese statunitensi il diritto di possedere, utilizzare, vendere e trasportare le risorse spaziali estratte da corpi celesti, a condizione che tali attività siano svolte nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dagli Stati Uniti. Il legislatore americano, pur ribadendo formalmente l’adesione al principio di non appropriazione, introduce di fatto una disciplina proprietaria sulle risorse, senza tuttavia rivendicare alcuna sovranità sul corpo celeste stesso (cfr. 51 USC § 51303).
Il Lussemburgo, invece, si è dotato di una delle legislazioni più avanzate in Europa in materia di space mining, con la legge del 20 luglio 20173, la quale dichiara le risorse spaziali “susceptibles d’appropriation” previa autorizzazione ministeriale, subordinata a rigorosi requisiti di solidità finanziaria, di governance, di gestione del rischio e di trasparenza societaria (articoli 6-10). Il sistema prevede, inoltre, controlli sia ex ante sia in itinere, nonché la responsabilità piena dell’operatore per i danni eventualmente causati dalla missione.
Anche negli Emirati Arabi Uniti, la Federal Law n. 12/2019 promuove un regime di licenze per l’esplorazione e l’utilizzo delle risorse spaziali, incentivando la collaborazione tra settore pubblico e privato e imponendo stringenti obblighi di due diligence, trasparenza e copertura assicurativa.
Tali approcci, pur non violando formalmente l’articolo II dell’OST, in quanto circoscritti alle risorse mobili e non al corpo celeste in sé, rischiano tuttavia di generare una frammentazione normativa e fenomeni di forum shopping, con conseguenti potenziali tensioni tra Stati e impatti significativi sulle procedure di registrazione degli oggetti spaziali (articolo VIII OST e Convenzione sulla Registrazione del 19764), nonché sulla ripartizione della responsabilità in caso di danni (Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per danni causati da oggetti spaziali, 19725).
Il fallimento (parziale) del Moon Agreement e la rinascita della soft law
L’Accordo sulla Luna del 1979 (“Moon Agreement”)6, il quale qualifica le risorse lunari come «patrimonio comune dell’umanità» e subordina il loro sfruttamento all’istituzione di un futuro regime internazionale (articolo 11), ha registrato una scarsa adesione, essendo stato ratificato da soli diciotto Stati Parte e non includendo alcuna delle principali potenze spaziali, rimanendo pertanto privo di effettiva cogenza. In assenza di un quadro vincolante, la comunità internazionale ha visto emergere tre principali filoni di soft law.
In primo luogo, le linee guida UNCOPUOS e i report del Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities (2023-2025), elaborati nell’ambito del Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) e dell’Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), promuovono principi di trasparenza, consultazione internazionale, notifica preventiva delle attività e meccanismi di benefit-sharing progressivo; tuttavia, tali strumenti7 non hanno valore cogente e si fondano esclusivamente sulla volontarietà degli Stati.
In secondo luogo, gli Artemis Accords8, promossi dalla NASA nel 2020 e sottoscritti da oltre trentacinque Paesi, fissano principi condivisi in materia di trasparenza, interoperabilità, registrazione delle attività e istituzione di “zone di sicurezza” (safety zones); tuttavia, tali accordi lasciano irrisolta la questione della redistribuzione dei benefici e della governance multilaterale delle risorse. Infine, la crescente attenzione alla mitigazione dei detriti, alla planetary protection e alla due diligence ESG si riflette nell’adozione di standard tecnici, quali ad esempio la ISO 24113:2021 per la mitigazione dei detriti spaziali, e di linee guida industriali, che stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante per l’accesso ai finanziamenti e alle coperture assicurative.
La proliferazione di tali regimi volontari rischia, tuttavia, di generare conflitti interpretativi e un’incertezza giuridica significativa, in particolare per quanto concerne la legittimità dei cosiddetti “diritti esclusivi di utilizzo” (quasi-property rights) concessi unilateralmente dagli Stati.
Prospettive di un regime multilaterale “a geometria variabile”
Alla luce delle profonde divergenze normative e della crescente eterogeneità degli approcci nazionali, la dottrina9 ha avanzato proposte per l’istituzione di un regime multilaterale ispirato alla Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS). Tale modello prevederebbe:
- l’istituzione di un’Autorità internazionale per le risorse spaziali, dotata di poteri di licensing, monitoraggio e enforcement;
- meccanismi di condivisione dei benefici (benefit-sharing) e di trasferimento tecnologico a favore dei Paesi in via di sviluppo, per evitare nuove forme di esclusione o “colonialismo spaziale”;
- la creazione di un tribunale arbitrale specializzato per la risoluzione delle controversie tra Stati e operatori privati.
Tuttavia, la mancanza di un consenso internazionale e le resistenze politiche – in particolare da parte degli Stati che hanno già adottato legislazioni nazionali competitive – ostacolano l’attuazione di un simile regime. In tale contesto, l’Unione Europea, pur non disponendo di una competenza esclusiva in materia di space mining, potrebbe assumere un ruolo di normative influencer: una posizione comune UE-ESA, integrata nel Regolamento (UE) 2021/696 che istituisce il Programma Spaziale dell’Unione10, potrebbe infatti fissare standard minimi di sostenibilità, trasparenza e due diligence per gli operatori europei, con l’ambizione di proiettare tali regole anche a livello internazionale.
Aspetti tecnici e responsabilità: dal risk allocation alla copertura assicurativa
Le missioni di estrazione richiederanno l’impiego di piattaforme robotiche in-situ, infrastrutture di trasporto cislunare e sistemi avanzati di monitoraggio, comportando elevati profili di rischio tecnico, operativo e giuridico. Tali rischi sono oggetto di crescente attenzione sia da parte delle agenzie spaziali, quali ESA e NASA, sia da parte delle compagnie assicurative e degli investitori istituzionali.
Per quanto concerne i detriti e le collisioni, l’aumento esponenziale di payload e satelliti destinati all’orbita lunare e cislunare rende imprescindibile l’integrazione di requisiti di Space Traffic Management (STM) nei processi autorizzativi.
La normativa statunitense (Commercial Space Launch Competitiveness Act, titolo IV) e i più recenti report NASA-MITRE sottolineano la necessità di adottare standard condivisi per la mitigazione dei rischi di collisione e la gestione dei detriti, anche in un’ottica di responsabilità internazionale. In materia di contaminazione planetaria, le COSPAR Guidelines e le raccomandazioni UNCOPUOS impongono limiti particolarmente stringenti alle attività che possano compromettere l’integrità scientifica o ambientale dei corpi celesti. Tali standard possono essere recepiti come condizioni vincolanti nelle licenze nazionali, in attuazione degli articoli VI-IX dell’OST, e risultano sempre più richiesti anche dagli investitori e dalle compagnie assicurative.
Per quanto riguarda l’assicurazione e la responsabilità, l’allocazione dei rischi dovrà necessariamente tener conto della responsabilità oggettiva prevista dall’articolo VII dell’OST per i danni causati da oggetti spaziali sulla Terra o nello spazio, nonché delle reciprocal waivers of claims previste nei contratti di lancio (cfr. § 107 U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act).
In prospettiva, potrebbe rendersi opportuna un’estensione dei regimi di indennizzo statale e di copertura assicurativa obbligatoria, soprattutto a beneficio dei piccoli operatori e delle start-up che avviano attività estrattive dal territorio di uno Stato.
Considerazioni economiche e di finanziamento
Il business case dello space mining si presenta, allo stato attuale, come altamente speculativo, poiché le sfide tecnologiche – quali lo sviluppo di tecnologie di in-situ resource utilization, il trasporto interplanetario e la raffinazione in ambiente ostile – unitamente agli elevati costi e alle persistenti incertezze regolatorie, incidono negativamente sulla bancabilità dei progetti e sul valore atteso dei flussi di cassa.
Nonostante ciò, si registrano segnali di crescente interesse.
Secondo i dati di mercato più recenti, relativi al 2025, gli investimenti venture capital in tecnologie di prospezione, robotica lunare e sistemi ISRU hanno superato i tre miliardi di dollari, con la partecipazione di fondi sovrani del Golfo, agenzie spaziali quali ESA e NASA, nonché numerose partnership pubblico-private. Inoltre, la finanza sostenibile e i principali investitori istituzionali iniziano a richiedere, in via preliminare, Environmental and Social Impact Assessments (ESIA), i quali possono essere integrati nei processi di licenza nazionali e rappresentano ormai un prerequisito per l’accesso a capitali e coperture assicurative. Le strategie di off-take agreement con l’industria chimica, energetica e aerospaziale – ad esempio per l’approvvigionamento di ossigeno e idrogeno da utilizzare come propellenti lunari – costituiscono, infine, la principale leva di bancabilità e di riduzione del rischio commerciale.
In prospettiva, la creazione di un quadro normativo chiaro e armonizzato, sia a livello internazionale sia nazionale, si rivelerà determinante per attrarre investimenti e favorire la crescita di una space economy sostenibile e inclusiva.
La corsa alle risorse spaziali pone il diritto internazionale dinanzi a un bivio cruciale: da un lato, occorre conservare la centralità del principio di non appropriazione sancito dall’OST, evitando che lo spazio si trasformi in un nuovo terreno di competizione estrattiva priva di regole condivise e di meccanismi di benefit-sharing; dall’altro, è necessario garantire agli operatori certezza giuridica, tutela degli investimenti e condizioni di parità di accesso, elementi imprescindibili per finanziare missioni ad alto rischio e favorire l’innovazione tecnologica.
La soluzione più realistica sembra risiedere nell’adozione di un regime multilivello, fondato su accordi intergovernativi “aperti” (sul modello degli Artemis Accords), accompagnati da standard internazionali minimi e da best practice condivise, recepiti nei diritti nazionali tramite clausole di adattamento automatico. Solo un approccio inclusivo e multilivello potrà realmente coniugare l’incentivo all’innovazione con la responsabilità collettiva verso l’“umanità intera” evocata dall’OST, garantendo che lo spazio rimanga una provincia comune e non si trasformi in una nuova frontiera di law shopping e di conflitti geopolitici.
Per ulteriori approfondimenti sul quadro giuridico internazionale dello spazio, si rinvia all’articolo pubblicato a maggio 2025: “Il quadro giuridico internazionale dello spazio” (LEXIA, maggio 2025) >
- (1) Il testo integrale dell’OST è disponibile all’indirizzo https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html ↩︎
- (2) Public Law 114–90, Titolo IV, “Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015”, il cui testo è consultabile su https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf ↩︎
- (3) Testo integrale disponibile su https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a674/jo ↩︎
- (4) https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/registration-convention.html ↩︎
- (5) https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/liability-convention.html ↩︎
- (6) testo disponibile su https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/moon-agreement.html ↩︎
- (7) I report e le linee guida sono consultabili all’indirizzo https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/space-resources/index.html ↩︎
- (8) Testo disponibile su https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/index.html ↩︎
- (9) Tra cui si segnalano, in particolare, i contributi di P. Stubbe (“Developing a Global Order for Space Resources – A Regime Evolution Approach”, Georgetown Journal of International Law, Vol. 51, 2020, pp. 315–364) e di Yannick Radi (“Space Mining in Practice: An International Space Law Perspective on Upcoming Challenges”, ESIL, 2024). ↩︎
- (10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0696 ↩︎