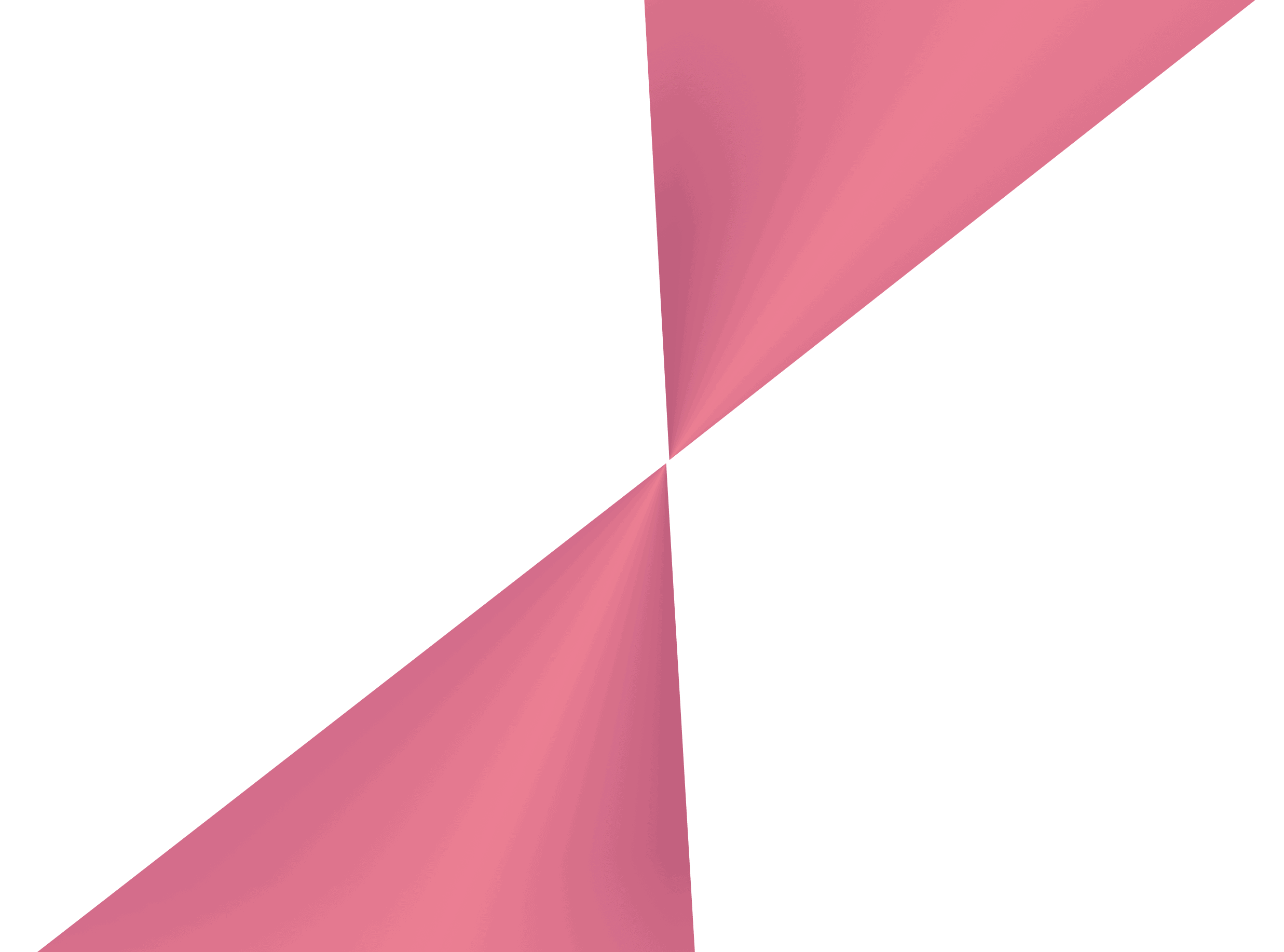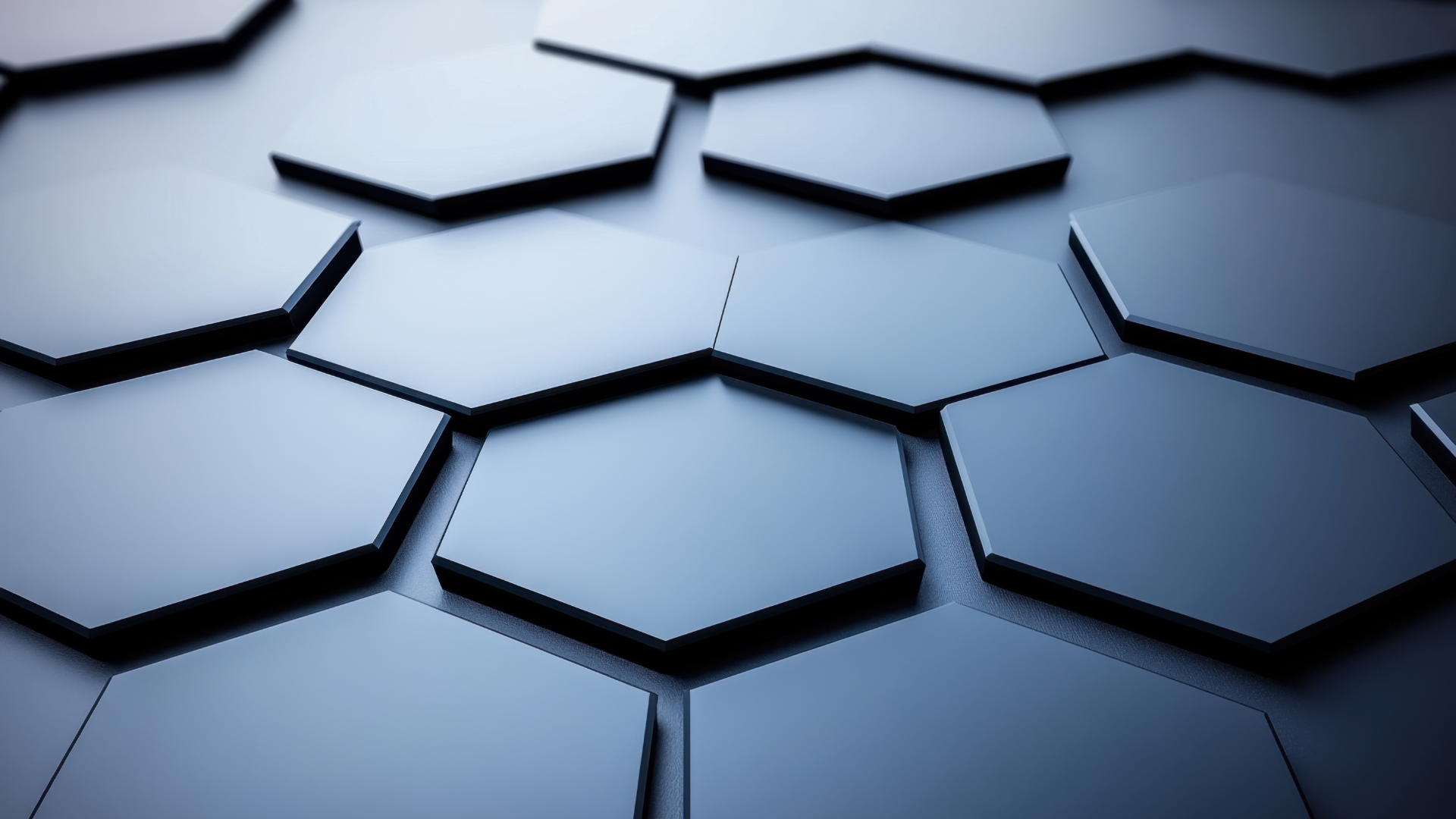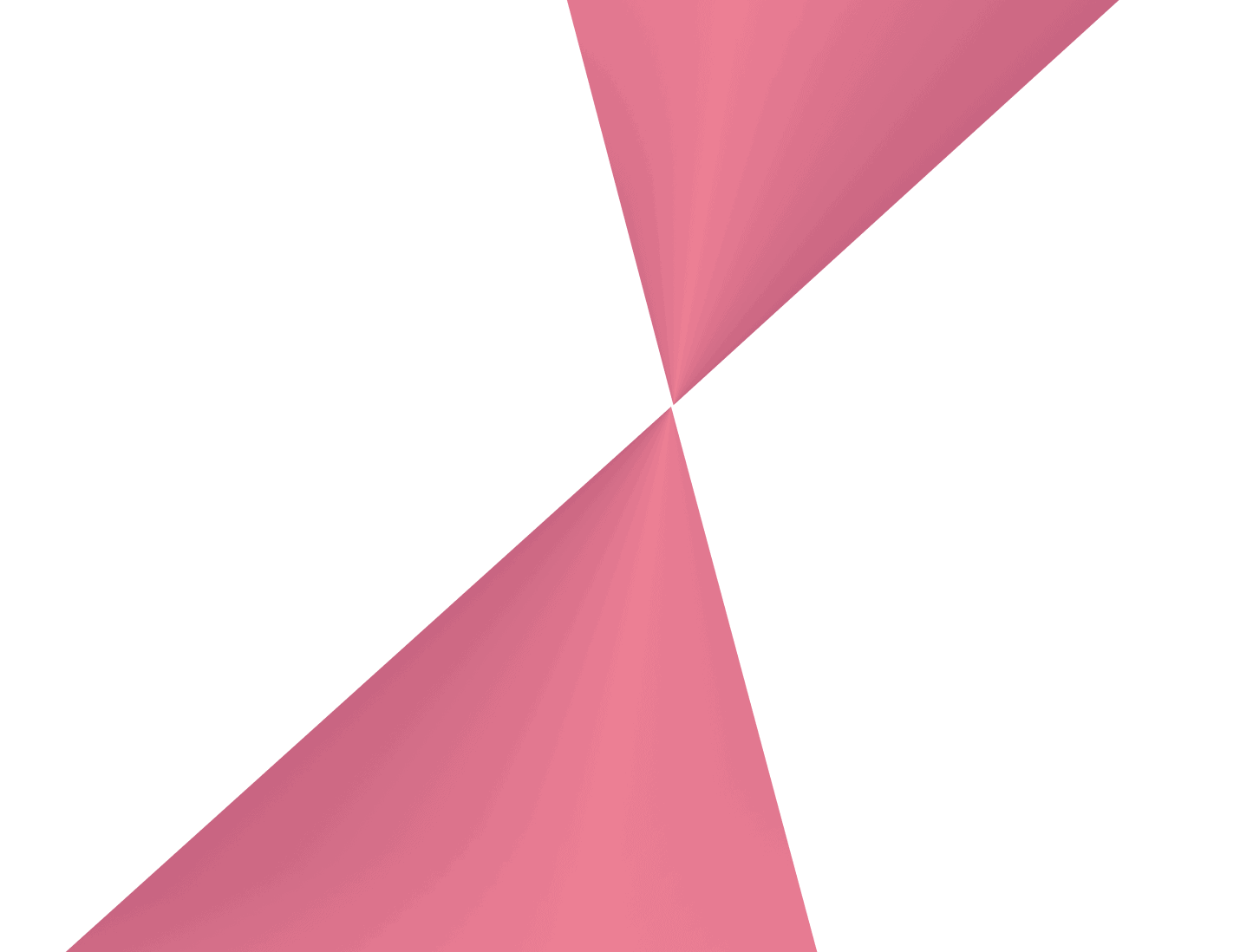Il procedimento penale attualmente pendente nei confronti del content creator, Francesco Salicini, alias “Once Were Nerd”, ha attirato notevole attenzione nei settori legale-tech e della proprietà intellettuale.
L’attività online di Salicini consiste principalmente nella produzione di contenuti audiovisivi in cui vengono recensiti e mostrati sia videogiochi di recente uscita sia titoli vintage degli anni ’70, ’80 e ’90. Il suo canale ha incluso anche presentazioni di console portatili basate su sistemi Android, prodotte da aziende come Powkiddy, TrimUI e Anbernic, molte delle quali incorporano emulatori che replicano piattaforme di gioco storiche come Nintendo 64, PlayStation Portable e vari sistemi Sega.
La Guardia di Finanza, nel mese di aprile 2025, ha eseguito il sequestro di trenta console portatili appartenenti al content creator, con l’accusa di grave violazione del diritto d’autore: l’indagine trae origine da una recensione pubblicata in cui Salicini mostrava una console Anbernic precaricata con numerosi file ROM di videogiochi vintage, molti dei quali appartenenti ai cataloghi Sony e Nintendo, senza la necessaria autorizzazione dei rispettivi titolari dei diritti.
Secondo l’accusa, il comportamento contestato andava oltre la semplice esposizione di contenuti illeciti, includendo: (i) la diffusione di istruzioni tecniche dettagliate per la configurazione di emulatori con software non autorizzato; (ii) la fornitura di link a repository online di ROM pirata; e (iii) l’organizzazione di vendite e aste di tali console tramite gruppi privati su Telegram.
Complessivamente, tali azioni sono state interpretate come un’evoluzione della questione da una possibile violazione civile a un comportamento in grado di costituire reato secondo la normativa vigente.
Il framework normativo italiano: la violazione dell’articolo 171-ter lda
Il caso Once Were Nerd mette in evidenza la complessità intrinseca dell’enforcement del copyright nel settore del retro gaming. Secondo la legge italiana, il comportamento contestato rientra nell’ambito di applicazione dell’Articolo 171-ter della Legge sul diritto d’autore (Legge n. 633 del 22 aprile 1941, “LDA”). Tale disposizione sanziona, quando effettuata a scopo di lucro e non per uso privato, la duplicazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la facilitazione dell’uso non autorizzato di opere protette da copyright o di copie illegali. L’Articolo 171-ter LDA sanziona anche forme indirette di promozione, estendendo la responsabilità a chi, pur senza distribuzione diretta, aumenta la visibilità o l’accessibilità di contenuti illeciti in maniera tale da generare un beneficio economico.
Il quadro normativo risulta particolarmente rigoroso, in quanto le pene previste dall’articolo 171-ter comprendono la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre a multe da 2.500 a 15.000 euro. La disposizione stabilisce inoltre che qualsiasi atto che contribuisca alla diffusione pubblica di opere illecite, compresi i contenuti digitali monetizzati attraverso piattaforme come YouTube, può costituire una facilitazione indiretta sufficiente a determinare la responsabilità penale. Questo approccio interpretativo è stato richiamato dall’accusa nel presente caso, considerata la combinazione di dimostrazione, istruzione tecnica e legame commerciale.
Oltre all’articolo 171-ter, la normativa italiana sul diritto d’autore interagisce con molteplici livelli di tutela della proprietà intellettuale. I videogiochi sono protetti sia come opere audiovisive autonome sia attraverso la protezione distinta dei singoli elementi costitutivi, come codice sorgente, interfacce grafiche e composizioni musicali. I titoli di gioco possono inoltre essere registrati come marchi, conferendo diritti esclusivi sul loro sfruttamento commerciale, mentre innovazioni tecnologiche — come meccanismi di controllo, sistemi interattivi o caratteristiche hardware uniche — possono essere soggette a tutela brevettuale. Di conseguenza, un singolo atto di violazione può coinvolgere più diritti e percorsi di enforcement, ciascuno soggetto a regole procedurali e sostanziali distinte.
Sfruttamento commerciale senza autorizzazione
La questione giuridica centrale riguarda la possibilità di sfruttare commercialmente un software protetto senza il consenso espresso dei titolari dei diritti. La legge italiana fornisce una risposta chiara: è vietato. Tuttavia, l’enforcement pratico si scontra con ostacoli strutturali nel mercato del retro gaming. I contenuti che mostrano software non autorizzato possono facilitare indirettamente canali alternativi di distribuzione di ROM pirata, incrementando la domanda di dispositivi non conformi e generando danni economici quantificabili ai legittimi titolari dei diritti.
Una sfida dottrinale centrale riguarda la distinzione tra commento culturale legittimo, recensione o uso educativo (che può rientrare nelle eccezioni per citazione, ricerca o fair dealing) e comportamenti che superano la soglia della facilitazione attiva della violazione. Nel presente procedimento, l’accusa sostiene che la combinazione di dimostrazione, guida tecnica e monetizzazione renda i contenuti un veicolo per la pirateria, oltrepassando i limiti consentiti dall’uso legale.
Tutela del patrimonio videoludico
Il caso pone in primo piano un dibattito di politica culturale critico sulla conservazione del patrimonio digitale. Molti videogiochi vintage non sono più accessibili legalmente perché l’hardware originale non è più in produzione e non esistono versioni digitali autorizzate. In tali circostanze, l’emulazione diventa spesso l’unico mezzo praticabile per fruire di queste opere, nonostante il suo frequente legame con la pirateria.
Università, musei e organizzazioni no-profit, tra cui la Video Game History Foundation, sostengono che l’emulazione controllata serva a scopi archivistici legittimi. Essi argomentano che, analogamente ai film e alle opere letterarie classiche, i videogiochi fanno parte del patrimonio culturale e devono essere preservati per garantire un accesso pubblico duraturo. Questa prospettiva è in linea con principi più ampi di politica culturale che considerano la conservazione dei formati mediatici obsoleti un bene pubblico.
Once Were Nerd evidenzia la tensione tra la necessità di un enforcement robusto dei diritti di proprietà intellettuale e l’imperativo di preservare i beni culturali digitali. Le risposte legali e politiche dovrebbero mirare a un equilibrio: ad esempio, istituendo quadri di licenza per titoli storici, ampliando le eccezioni normative per consentire a istituzioni accreditate di conservare opere obsolete e rafforzando la cooperazione internazionale per colmare le lacune giurisdizionali che permettono ai produttori non conformi di operare impunemente.
Un approccio coerente deve conciliare gli interessi economici dei titolari dei diritti con l’interesse legittimo della società a mantenere l’accesso a opere storicamente e culturalmente significative. Ciò risulta particolarmente vitale nell’era digitale, caratterizzata da rapida obsolescenza, canali di distribuzione globali e crescente riconoscimento del valore culturale dei media interattivi da parte dei sistemi giuridici e delle istituzioni culturali.
Il procedimento Once Were Nerd ha il potenziale di diventare un precedente di rilievo nell’applicazione del diritto penale sul copyright nel settore dell’intrattenimento digitale, illustrando la tensione persistente tra l’imperativo legale di proteggere la proprietà intellettuale e quello culturale di preservare opere non più disponibili commercialmente.
Per i professionisti del diritto, gli operatori del settore e i policy maker, la lezione chiara è che il diritto d’autore deve evolvere per affrontare sia le sfide dell’enforcement sia la salvaguardia del patrimonio culturale digitale, rendendo innovazione e conservazione pilastri complementari di un moderno regime di proprietà intellettuale.